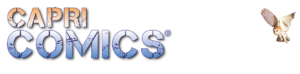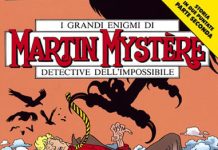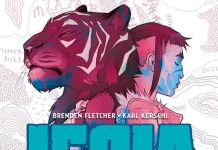COSA SOGNA LA FORESTA? VIAGGIO SU KELLER 300-B
Di Kenny Anoa’i-Okada
Kenny Anoa’i-Okada è xenobiologo e autore specializzato nello studio delle ecologie post-sintetiche sviluppatesi in seguito alla diaspora androidica. I suoi lavori indagano l’intersezione tra biodiversità e intelligenza artificiale ambientale. Per CIEX Papers ha pubblicato “José Fukanaga e la conquista dell’impossibile: un anno su Kando 425-XY”.
Atterrati su Keller-300B non riesco a non pensare al fastidio che mi sta provocando il nuovo impianto tracheale che abbiamo dovuto indossare per respirare l’aria di questo pianeta. Due giorni prima dell’atterraggio io e i membri dell’equipaggio siamo stati sottoposti a un intervento chirurgico di routine: la nostra trachea precedente è stata rimossa per inserirne una nuova, biomeccanizzata. Nel torace sono stati inseriti espansori pleurici artificiali, mentre al collo ci è stato applicato un collare dermo-sublinguale, innestato per rilasciare enzimi modulari antirigetto. Il sapore metallico degli enzimi è ancora presente in fondo alla gola, e ogni respiro è accompagnato da un leggero bruciore, come se l’aria fosse troppo viva per i nostri polmoni modificati.
Non è la prima volta che sono obbligato a sottopormi a un intervento del genere, si tratta di prassi nell’esplorazione extra-planetaria, eppure non riesco a non focalizzarmi sul pizzicore che provo ogni volta che respiro. L’atterraggio su Keller-300B ha richiesto alcune accortezze, necessarie per la sopravvivenza su un pianeta come questo: la sua atmosfera è satura di ossigeno, irrespirabile per impianti modulati sull’atmosfera terrestre. Abbiamo dovuto indossare tute biomeccaniche per resistere alla sua gravità, due volte quella terrestre e addirittura tre volte quella di Nova 47221, il pianeta da cui provenivamo. Abbiamo dovuto anche innestare nuovi adattatori oculari, perché la luce della stella di Keller-300B, una nana arancione di classe K2V2, è virata verso l’infrarosso, motivo per il quale saremmo stati, coi nostri occhi naturali, praticamente ciechi.
“Benvenuti sul pianeta delle meraviglie!” ci urla il professor Fukanaga mentre ci viene incontro con tutta la sua squadra presso il punto di atterraggio, attraverso il folto di una foresta di piante tropicali dai colori violacei e enormi funghi bioluminescenti che colano una sostanza resinosa dall’odore dolciastro e acido al tempo stesso. Ogni ramo sembra vibrare leggermente al nostro passaggio, come se l’intera vegetazione fosse connessa da un sistema nervoso comune.
Il professor Fukanaga è stato il primo essere umano ad atterrare su Keller-300B e il primo a studiare le specie che lo abitano. Ed è in questo posto che ha fatto la scoperta per la quale siamo noi qui oggi.
“È incredibile: delle centinaia di pianeti trovati e studiati dopo il Lemma di Nagoya3, questo ha mostrato un’evoluzione davvero rara degli androidi, forse unica. È una specie completamente diversa da qualsiasi altra mai incontrata. Ma lo vedrete coi vostri occhi domattina, è davvero difficile spiegarlo a parole, è qualcosa di mai visto.”
Non stento a credere alle parole del professore. Fukanaga è uno dei massimi studiosi di xeno-biologia androide4, sono innumerevoli i pianeti da lui scoperti e analizzati. I suoi studi su Kando 425-XY hanno cambiato la nostra comprensione dell’intelligenza sintetica post-terrestre5, eppure non ricordo di averlo mai visto così agitato, quasi euforico. Ci guida lungo un sentiero instabile tra radici serpentine e vapori intermittenti. Il centro studi è una struttura circolare, appiattita contro la collina come un organismo adeso a un corpo più grande. I materiali sembrano riflettere le iridescenze dell’ambiente circostante, come se anche l’edificio avesse imparato a mimetizzarsi. Tutto intorno, la foresta si muove. Si colgono sagome fugaci tra le fronde: non camminano né volano, piuttosto sembrano strisciare con lentezza, piegando le piante al loro passaggio. “Hanno percepito una variazione nel paesaggio biochimico, sanno del vostro arrivo” dice il professore. Il suo tono è pacato, ma percepisco un brivido nella voce. Sì, lo sanno. Ma chi sa?
Prendiamo posto nei nostri alloggi, qui finalmente possiamo spogliarci dell’esoscheletro e muoverci con più agilità, accolti dal modulatore di gravità del centro studi. La stanchezza ci pesa addosso come un secondo strato di pelle. Senza perderci in grandi chiacchiere con l’equipaggio, chiediamo al professore di poter andare a dormire.
“Certo, non vi preoccupate. Dovete riposare, domani sarà un grande giorno.”
Keller-300B è stato scoperto circa tre anni fa, e fin da subito è diventato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori, molti dei quali si sono contesi con insistenza l’opportunità di lavorare sotto la supervisione del professor Fukanaga. Il pianeta si trova a circa tre anni luce dalla fascia di Grossmann, nel settore occidentale della spirale di Lavrentiev. L’area è oggi comunemente indicata come “la Strada dei Mattoni d’Oro” o, in modo più evocativo, “la Via di Dorothy”. Il nome è un riferimento a un antico racconto popolare terrestre, Il Mago di Oz, in cui una bambina, per trovare ciò che cerca, deve seguire una lunga strada fatta di mattoni d’oro, sempre perfettamente visibile. Nessun nome poteva essere più azzeccato: la Via di Dorothy è infatti un percorso chiaro, una sequenza lineare di sistemi planetari terraformati con successo dagli androidi, che rende tangibile il tracciato da loro seguito. In nessun altro quadrante finora esplorato avevamo trovato una prova così netta del loro passaggio, così visibilmente organizzata6.
La mattina seguente, dopo una notte di sonno disturbato da sogni incerti e una colazione rapida, ci presentiamo finalmente in modo formale. La squadra del professor Fukanaga è composta da quattro membri, incluso lui. La dottoressa Ana Gonzalez è la linguista del gruppo; Kohler è uno specialista in neuro-semiotica ambientale7, un campo ancora in via di definizione: si occupa della relazione tra configurazioni corporee e ambiente narrativo, con particolare attenzione alle interfacce non antropocentriche. Infine, il dottor Castor è l’antropologo di riferimento, sebbene la sua figura sfoci spesso in quella del teorico culturale: analizza non solo comportamenti ma sistemi simbolici alieni, quando questi si manifestano attraverso mutazioni spaziali, rituali o pattern vegetativi. Le emergenze mediche sono totalmente affidate alle unità robotiche del centro studi, completamente autonome, silenziose e sempre operative.
I miei compagni di viaggio hanno un compito piuttosto semplice: sono qui per dare il cambio ai collaboratori del professor Fukanaga.
Se inizialmente Keller-300B apparve sì come un pianeta straordinario, ma uno dei tanti facenti parte di quella eccezionalità che è la Via di Dorothy, dopo la prima esplorazione di Fukanaga e del suo equipaggio le cose apparvero chiare in tutta la loro unicità: la terraformazione di Keller e la sua accelerazione artificiale avevano portato alla nascita e allo sviluppo di una specie di androidi differente da qualsiasi altra finora incontrata, un unicum che aveva dell’eccezionale. I corridoi di tutti gli uffici del CIEX (Comitato Interstellare di Etica Xenobiologica)8, organo dal quale provengono tutti i presenti, compreso il sottoscritto, rimbombavano delle notizie sulle scoperte incredibili che Fukanaga stava facendo su Keller. Quelle scoperte sono il motivo per cui siamo qui oggi.
Dopo una colazione abbondante alla base, ci prepariamo alla nostra prima esplorazione su Keller 300-B. Mentre indossiamo gli esoscheletri di superficie, noto un silenzio diffuso, quasi sospeso, come una tensione densa che ha preso corpo nell’aria. C’è attesa, e insieme un filo di timore.
“È difficile essere pronti in questi momenti. È sempre straordinario scoprire una nuova specie, ma quando si tratta di qualcosa come questo… beh, non c’è alcun manuale che possa davvero prepararti”, mi dice Kohler mentre varchiamo la soglia della stazione.
È mattino. O meglio, è ancora mattino. Le giornate su Keller 300-B sono profondamente diverse da quelle terrestri: il pianeta ha un periodo di rotazione di 66 ore, divise in 33 di luce e 33 di buio. Il ciclo prolungato favorisce attività biologiche complesse, nonché una biodiversità notturna straordinariamente sviluppata, grazie alle lunghe ore di oscurità che stimolano bioluminescenze, simbiosi miceliali e meccanismi di percezione non visiva. Keller non è in rotazione sincrona, ma presenta oscillazioni assiali regolari – simili a quelle di Nova 4722 o di Mercurio – che hanno generato zone stabili di luce diffusa. È proprio in una di queste zone che ci troviamo ora. Qui, la flora si è evoluta in forme avvolgenti, ramificate e orizzontali, modellate tanto dalla fotosintesi costante quanto dalla forte gravità.
“Abbiamo un po’ di strada da fare”, dice Fukanaga. Iniziamo a risalire un pendio immerso nella vegetazione fitta. Attorno a noi, sospesi a mezz’aria, si muovono in piccoli sciami i trafoglifi: sacche vegetali iridescenti, simili a bolle semitrasparenti, che emettono un bagliore pulsante. Grazie alle nuove reti oculari, possiamo percepire l’impulso fotoelettrico azzurrino che emettono a intervalli ritmici. Le piante vicine sembrano rispondere a questi segnali come in una catena sincronica. Grandi liane spiraliformi – spire fotoematiche – avvolgono i tronchi e trasmettono onde di luce che si propagano lungo le fibre vegetali. Il tutto è accompagnato da un ronzio di fondo e da un odore penetrante, quasi alcalino.
La foresta mette alla prova ogni nostro senso. E non siamo ancora davvero entrati.
“Stanno comunicando i nostri spostamenti”, sussurra la dottoressa Gonzalez, quasi con rispetto.
Poco più avanti, il professor Fukanaga mi indica delle imponenti strutture ramificate, simili ad alberi equatoriali, che sembrano fungere da sostegno invisibile all’intero ambiente. “Quelli sono alveorami. Costituiscono la rete neurale della foresta9. I nostri odori, le nostre forme, il battito cardiaco e persino la composizione dei nostri impianti biomeccanici sono già stati registrati e archiviati nei loro canali linfatici.”
Procediamo in fila, immersi in un paesaggio che sembra alterarsi a ogni passo. I trafoglifi, che prima fluttuavano liberi in gruppi sparsi, ora ci seguono a distanza regolare, come se stessero misurando la nostra traiettoria. Le spire fotoematiche, avvolte attorno ai tronchi, reagiscono con una tenue fluorescenza azzurra ogni volta che ci avviciniamo a un nuovo nodo vegetale. È come camminare dentro un sistema di segnalazione vivente, una foresta che ci sta codificando in tempo reale10.
Nessuno parla. Il rumore delle nostre tute è attutito dal suolo spugnoso, saturo di radici superficiali e filamenti micelici che si intrecciano come nervature. La luce, costante ma diffusa, filtra tra le fronde dense, spostandosi di pochi gradi ogni ora, rendendo ogni cambiamento impercettibile ma inesorabile.
Fukanaga si volta verso di me e rompe il silenzio.
“È la cosa che più disorienta, sai? La costanza. Il fatto che il paesaggio non sembri mai cambiare, eppure a ogni ritorno trovi qualcosa che prima non c’era.”
Mi guardo intorno. In effetti, anche le piante sembrano in uno stato di perenne metamorfosi: lo stesso gruppo di fronde che dieci minuti fa era immobile, ora pulsa di luce viola lungo le venature. Alcune hanno assunto una forma diversa, come se avessero ruotato su se stesse. Ma non abbiamo mai sentito alcun rumore.
“È un paesaggio narrativo,” continua Fukanaga. “Non si limita a crescere. Si orienta in base a chi lo attraversa.”
A sinistra, tra le radici semi-emerse, intravedo un gruppo di piccoli organismi striscianti. Sembrano vertebrati, ma il movimento è troppo sincrono, troppo calmo.
Uno di loro si ferma, ruota lentamente la parte anteriore del corpo e solleva una membrana opalescente simile a un velo: sotto, non c’è un volto, ma una superficie vibrante, attraversata da riflessi interni. Li osservo. Non sembrano infastiditi, ma è evidente che ci stanno osservando a loro volta.
“Li chiamiamo crostemorfi,” sussurra Kohler. “Hanno un sistema di lettura epidermica. Rilevano le variazioni di temperatura e pressione atmosferica legate alla nostra presenza, e reagiscono modulando i pigmenti delle membrane sensoriali. Quella ‘faccia’ che hai visto è in realtà una forma di traduzione biologica.11”
Più avanti, tra due tronchi coperti di lichenocristi, vediamo un movimento verticale. È lento, quasi impercettibile. Una creatura alta almeno due metri si muove all’indietro lungo il fusto di un albero. Il suo corpo è segmentato in placche traslucide, e sul dorso emette una luce intermittente simile a un campo elettrico in fase di scarica. Quando ci avviciniamo, si dissolve lentamente nel fogliame, senza lasciare traccia.
“Un vargiletto,” annuncia il dottor Castor. “Non sono comuni in questa zona. Probabilmente è venuto a registrare il nostro passaggio.12”
“Per vederci?” chiedo.
“No,” risponde lui. “Testimoniare.”
Camminiamo per quasi un’ora. Le piante si fanno più fitte, ma non ci ostacolano. Si piegano. Le tessilofite, sottili come nervature flessibili, sembrano delimitare un sentiero che non avevamo visto prima. Gonzalez si ferma, preme due dita contro una parete di lianidi di Embracis e ne rileva l’impulso.
“Questo non è un tracciato naturale. È stato attivato,” dice.
“Da chi?” chiede uno di noi.
Gonzalez non risponde.
Attraversiamo un passaggio vegetale, quasi un arco formato da frondàli mobili. All’interno, la luce cambia tonalità, diventando rosata e diffusa. L’aria è più fredda. Sul suolo, alcune lastre piatte di cristofrondi rifrangono i nostri movimenti in sequenze spezzate, come se stessero archiviando frammenti visivi.
“Stiamo entrando in una zona a densità storica elevata,” dice Fukanaga. “Qui il paesaggio non è solo reattivo. Qui conserva.”
“Conserva cosa?” domando. “Le traiettorie.”
Il sentiero si apre improvvisamente.
Non c’è alcun segnale. Nessuna variazione visibile nella luce, né nel suono. Semplicemente, il paesaggio si ritrae, come se avesse smesso di fingere di essere foresta.
Davanti a noi si estende una conca ampia, irregolare, incisa da rilievi muschiosi e pieghe di vegetazione flessibile. Le fronde superiori sembrano trattenere il respiro. Sotto i nostri piedi, il terreno pulsa piano, attraversato da filamenti densi, nervosi, che scorrono lenti come vene in superficie.
Ci fermiamo. Nessuno dice nulla. Poi li vediamo.
Non arrivano. Non emergono. Non compiono alcun gesto per farsi notare.
Eppure, sono lì. C’erano da prima. Non c’è un momento preciso in cui li distinguiamo dallo sfondo. È come se il nostro sguardo ci mettesse troppo tempo a capire cosa sta osservando. Come se i corpi, finora, si fossero lasciati percepire solo con la coda dell’occhio. Sono alti. Discontinui. Disallineati. Alcuni sembrano ricurvi, cresciuti in orizzontale lungo gli stessi fusti che li ospitano. Altri si reggono su strutture flessuose, articolate in nodi organici e segmenti che riflettono la luce come metallo corroso. La pelle-se è pelle-è spessa, attraversata da nervature mobili, aperture senza simmetria, fenditure che si richiudono a intermittenza, come branchie che non respirano aria.
In superficie, non c’è coerenza: in alcuni il corpo si frammenta, in altri si espande come se fosse ancora in crescita. Alcuni hanno porzioni traslucide da cui si intravede una trama interna che vibra, assomiglia a tessuti linfatici, ma risponde come una macchina. Altri portano addosso ciò che sembra materiale esausto: ruggine, micelio, chiazze organiche fuse con impianti, come se ciò che erano fosse stato restituito alla foresta pezzo per pezzo.
Dalla parte frontale del corpo, che non ha centro né simmetria, si dipartono filamenti mobili, sottili come radici aeree o antenne flessibili, che si allungano e si contraggono a ritmo irregolare. Non sembrano arti né strumenti, ma estensioni sensoriali: tastano il suolo, sfiorano l’aria, si intrecciano con le fibre vegetali come se leggessero, come se ricordassero.
Nessuno ha volto. Nessuno ha occhi. Non ci osservano. Non si voltano. Non reagiscono. Eppure, sappiamo di essere visti. Registrati. In qualche modo accolti e superati, come un elemento previsto nel paesaggio.
“È qui che li abbiamo avvistati per la prima volta,” mormora Fukanaga accanto a me. La sua voce è più quieta del solito. “Qui, tra le pieghe dei Lianidi, tra le cavità dei
Risonorami. Non c’è stato un giorno preciso. Solo un momento in cui ci siamo resi conto che non eravamo più soli.”
Non parlo. Non riesco a trovare una frase che non suoni banale.
Per un attimo, qualcosa si muove: un corpo, più massiccio degli altri, ruota su se stesso in modo impossibile, piegando la propria massa come una fronda spezzata che si ricompone. Non fa alcun suono. Ma il paesaggio attorno, sì: le spire fotoematiche cambiano frequenza, le tessilofite si irrigidiscono come corde tese. Le piante reagiscono a ciò che nemmeno noi comprendiamo.
Ogni fibra del mio corpo sa che questo è l’incontro. Non perché qualcuno ci accolga.
Ma perché finalmente possiamo vedere. Eccoli, il motivo per cui siamo qui: i Vireli.
NOTE
- Pianeta situato nella spirale di Novalis, distante circa diciotto anni di viaggio a tempo sospeso da Keller 300-B. Ospita il quartier generale del CIEX e funge da centro amministrativo e scientifico principale per tutte le missioni di osservazione e contatto con specie sintetiche post-diaspora. ↩︎
- Le stelle di sequenza principale K sono un po’ più fredde (da 4700 a 3000 K) e più piccole del sole terrestre e mediamente la loro luminosità assoluta è di 3 magnitudini inferiore a quella solare. ↩︎
- cf. Infra. ↩︎
- Fukanaga, J. (3472). “Oltre l’umano: tracciati di intelligenza autogenerata”. CIEX Papers. ↩︎
- Fukanaga, J. (3468). “Parole nella sabbia. Resoconto del primo viaggio su Kando 425-XY”. CIEX Papers. ↩︎
- Temple, D. (3466). “La Via di Dorothy: Storia dei Mattoni d’Oro sulla Via della Vita nell’Universo”.
Akamov Edizioni. ↩︎ - Per approfondire il concetto di neurosemiotica ambientale vedasi: Kohler, N. (3473) “Neurosemiotica di Base. Manuale Operativo” CIEX Papers. ↩︎
- Il CIEX (Comitato Interstellare di Etica Xenobiologica) viene fondato nel 3227 come organismo interplanetario indipendente, con il compito di coordinare e supervisionare lo studio delle forme di vita androidi rintracciate nella galassia a seguito del cosiddetto Lemma di Nagoya. Ogni ricerca condotta su pianeti extrasolari abitati, ogni pubblicazione in ambito di xenobiologia androide o teoria biopsicosociale applicata a entità astrobiologiche, è sottoposta a revisione e protocollo CIEX. La sede principale si trova su Nova 4722, ma la presenza di almeno un’unità operativa CIEX è obbligatoria, per statuto federale, su ogni pianeta colonizzato o classificato di interesse bioetico. ↩︎
- Gli esempi di reti neurali diffuse non sono rari e si riscontrano con particolare frequenza su pianeti con alta densità vegetale. Per un’analisi dettagliata, si veda: Lucille, C. (3476). “Una mente, molte menti. Studi su reti cripto-neurali diffuse nelle foreste della fascia di Kuyper.” Edizioni Rana Nera. ↩︎
- Fukanaga, J. (3480). “La Foresta che Parla. Studi sulla flora e la fauna di Keller 300-B”. CIEX Papers. ↩︎
- Gonzalez, A. (3481). “Epiderme e sensorio: strategie di traduzione nei crostemorfi” CIEX Papers. ↩︎
- Fukanaga, J. (3480). “La Foresta che Parla. Studi sulla flora e la fauna di Keller 300-B”. CIEX Papers. ↩︎
About the author

Maurizio Marras
Tutto quello che scrive/dice non va preso sul serio: è daltonico.