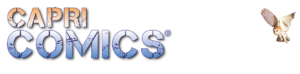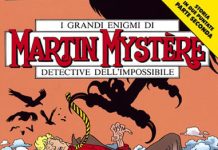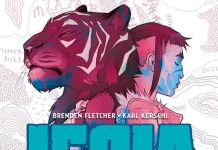Guardate lassù… è un uccello… è un aereo… è Superman… no, è un uomo come tutti noi.
Questo ci dice James Gunn, alla regia, scrittura e produzione del nuovo film dedicato all’uomo d’acciaio, nato nel 1933 dalla penna di Jerry Siegal e dalla matita di Joe Shuster.
E ci ricorda che, semmai, ciò che rende Superman davvero diverso, in una società mondiale sempre più cinica, non sono tanto i suoi superpoteri, ma il suo baricentro morale, la sua compassione, la sua gentilezza. Il suo vero superpotere è infatti saper riconoscere ciò che è sbagliato, immorale, ingiusto, e combatterlo, sacrificandosi e prendendosi le proprie responsabilità anche quando si rende necessario superare i confini di ciò che è lecito. Confini superati con dispiacere, non per boria o vanagloria, non perché si senta al di sopra della legge, ma perché a volte, uno sguardo dall’alto riesce a riportare le giuste prospettive.
Il Superman di Gunn è un distillato del meglio che il personaggio ha da offrire. Lontano dalle interpretazioni messianiche e perfettine, che lo hanno reso noioso agli occhi di molti, Gunn disegna un uomo con delle capacità sovraumane, ma che non per questo riesce, meglio o peggio di tutti noi, a trovare il proprio posto nel mondo, a farsi capire da chi ama, ad affrontare i propri doveri, ad accettare o a scendere a patti con la propria diversità.
Capitolo Uno: Dei e Mostri
Così si chiama il nuovo ciclo cinematografico del DC Universe (DCU), affidato a James Gunn e al produttore Peter Safran in qualità co-presidenti e co-CEO dei DC Studios. Iniziato ufficiosamente, quasi come una dichiarazione di intenti, con il film The Suicide Squad (2021) e la sua serie spin-off Peacemaker (2022–in corso), questo nuovo universo dedicato alle storie DC ha fatto poi il proprio debutto ufficiale con un’altra opera emblematica, Creature Commandos, serie d’animazione per adulti incentrata sulle missioni una squadra di black ops fuori dal comune. Deus di tutti questi prodotti è sempre James Gunn, che a poco a poco ha imposto un soft-reboot del precedente ciclo di film DC, spostando la bussola su storie dedicate alla diversità, alla fragilità, alla linea di demarcazione tra ciò che consideriamo umano e ciò che non lo sarebbe. Il tutto senza sacrificare il divertimento, l’emozione, lo spettacolo, la meraviglia, l’immediatezza, che vengono però adoperati non come fuochi d’artificio, bensì come strumenti per veicolare domande, e se possibile, riflessioni.
Superman 2025 segue questo solco, con una trama presto detta, e un sottotesto altrettanto semplice, ma non banale: mentre capisce il proprio ruolo nel mondo, Clark Kent, alias Superman, deve combattere contro la macchina del fango che Lex Luthor ha scatenato contro di lui.
Non vi spoileriamo altro, ma vi basti sapere, per correre al cinema a guardarlo, che questo film è come il personaggio che vuole rappresentare: luminoso, positivo, leale, divertente, empatico, popolare, ma non per questo privo di dubbi e insicurezze. Non è una origin story, non nel senso comune del termine, bensì una storia che approfondisce un’origine. Chi vi scrive lo promuove, anche al netto di alcuni difetti, come alcune soluzioni un po’ tirate via, una colonna sonora un po’ sottotono e un eccesso di personaggi piuttosto anonimi. Il comparto tecnico-creativo è una gioia per i sensi, l’azione è narrativa, gli scambi tra personaggi sono semplici ma efficaci, le interpretazioni sono solide, la progressione è intensa e ben calibrata.
Un divertissement in puro stile Gunn, un’infusione di adrenalina e positività circostanziate, che non risparmia anche qualche lacrimuccia e anche delle incursioni socio-politiche non da poco che richiamano palesemente l’invasione Russa dell’Ucraina alle stragi di Gaza. Se non l’avete ancora visto, rimediate. Per chi l’ha visto, invece, continuate a leggere per qualche considerazione più approfondita.

Uomini e Superuomini
Facciamo il verso alle idee di Nietzsche e alla commedia di Shaw, che le usa come una delle proprie ispirazioni, per introdurre uno dei temi che sottendono alla struttura di questo nuovo film di Superman, almeno a parere dello scrivente: l’insicurezza e il superomismo nella nostra epoca.
Sì, perché i due personaggi-motore della storia, Clark e Lex, sono mossi dalle stesse direttive, ma interpretate in maniera diametralmente opposta. Laddove dietro al tronfio superomismo di Lex vive una profonda insicurezza, dietro alla seria insicurezza di Clark vive il vero superomismo.
Tramite Lex, Gunn critica e attacca il comparto, ormai industria, del fango mediatico, della disinformazione, della vacuità, che altro non fa che dividere le persone, per poterle controllare meglio. Non solo. Lex Luthor è ciò che Elon Musk o Donald Trump sarebbero se avessero accesso ad apparecchi e attrezzature fantascientifiche: un sociopatico narcisista, invidioso e paranoico, mosso a scatti in avanti dal carburante tossico di un ego sproporzionato, ma fragile come un cristallo e messo costantemente in pericolo da ogni critica, anche la più basilare, anche quella di una ex fidanzata scontenta che lo insulta (a ragione) sul proprio blog. Nicholas Hoult dà una prova attoriale inquietante proprio perché realistica e familiare, tanto, troppo vicina a noi. Per Lex, Superman è un affronto, oltre che un nemico: lo vede come la fine dell’impegno umano, il limite dell’auto-miglioramento, la minaccia finale al culto dell’intelletto di cui lui si professa e crede Messia. Inoltre, ciò che Luthor non può tollerare, ammettere o anche solo comprendere, è che esista qualcuno di più potente di lui, e che usi il proprio potere per difendere e non per dominare. Vedendolo, ascoltandolo, viene da chiedersi se i veri super cattivi, oggi, non siano davvero questo, nient’altro che delle esasperazioni in cui ognuno di noi rischia facilmente di incarnarsi, quando diamo troppo ascolto al peggio di noi stessi.
Clark Kent è invece un ragazzone solare, ma profondamente insicuro, anche perché apparentemente disconnesso dalle proprie origini e incapace di comprenderle, tanto figurativamente quanto materialmente, vista l’incapacità di decifrare a pieno il messaggio dei suoi genitori biologici. Ciononostante, dentro di lui si muove l’idea che essere buoni, giusti, corretti, gentili è il vero punk-rock, la vera ribellione, la vera discontinuità, la vera non conformità, se la maggioranza è invece persa nell’odio, nelle divisioni, nella sopraffazione dei più deboli, nell’arrivismo scatenato, nell’abuso del potere. Superman prova a salvare tutti, ma proprio tutti: uomini, donne, bambini, mostri, animali, super cattivi. Ogni vita è importante, ognuno merita una seconda chance. E quando occorre, per il bene di tutti, porre fine ad una vita, per Superman è quella la vera sconfitta. Un ideale, questo, che lui credeva provenisse dai suoi genitori biologici, Jor-El e Lara, che in realtà lo hanno salvato solo per mettere in atto un piano di sopraffazione e dominio sulla terra. A partire da questa scoperta, il superomismo di Superman è infatti subito messo in discussione, sin dai primi secondi del film, che inizia in medias res, con un protagonista sconfitto, odiato, sull’orlo del baratro. Lex ha messo in crisi la sua identità, gli ha messo contro un clone di se stesso, barbarico, privo di valori, rappresentazione plastica tutto ciò che Superman potrebbe essere, se svuotato della propria moralità e manipolato da personaggi senza scrupoli. La vera rivelazione, che riporta l’eroe sui binari, è palese ma sfugge, come spesso sfuggono le rivelazioni più importanti: Clark capisce che l’ideale che lo muove gli è stato instillato dai suoi genitori putativi, Jonathan e Martha Kent, ma senza lezioni altisonanti, bensì col buon esempio, con l’amore, con la generosità, con la compassione, con l’empatia. E capito questo, niente più può fermarlo.
L’interprete, David Corenswet, iconograficamente perfetto, sa restituire fragilità e complessità, annidate appena dietro la scintillante positività del personaggio, senza però risultare affettato o pesante. Anche lui è un Superman molto vicino a noi, e al pari di Luthor coi supercattivi, ci fa interrogare sulla natura dell’eroe: forse ognuno di noi può ambire ad essere, a proprio modo, un eroe, ma senza volerlo, senza incaricarsene, senza presunzione, ma semplicemente scegliendo con consapevolezza e senso di giustizia tutti i giorni. Ed è infatti quello che avviene ad un personaggio secondario ma emblematico: Mali, il venditore di falafel, amico e sostenitore di Superman. Uomo semplice, altruista e coraggioso, Mali affronta la morte per mano di Lex Luthor con coraggio e senza rinunciare alla propria fede in Superman. È un atto di eroismo silenzioso, ma potentissimo, che il Daily Planet riconosce e piazza in prima pagina, a ribadire che tutti possiamo essere eroi.
Lois Lane e il suo rapporto con Clark e Superman rappresentano uno dei fulcri emotivi più riusciti del film. La Lois interpretata da Rachel Brosnahan si distingue per la sua indipendenza e forza intellettuale: è una giornalista determinata, capace di tenere testa con fermezza e acutezza a chiunque si trovi di fronte. Non si limita a essere un interesse amoroso o una spalla, ma si impone come parte attiva del discorso del film, ponendo domande profonde sulle implicazioni della presenza di un essere così potente tra gli esseri umani, interrogandosi sul suo impatto reale e sulle responsabilità che questa figura porta con sé. Il suo rapporto con Clark si sviluppa quindi su un terreno di fiducia e confronto continuo, dove si intrecciano amore, critica e una sincera volontà di comprendersi, non sempre facile. In quanto giornalista, Lois si fa sentinella, necessaria ad elevare il livello della discussione pubblica.
I comprimari, da Lanterna Verde a Hawkgirl, da Mister Terrific a Metamorpho, passando per i redattori del Daily Planet, primo su tutti Jimmy Olsen, sono divertenti, ma piuttosto insulsi e il loro compito sembra più che altro quello di dare colore all’universo narrativo ai fini di possibili futuri sviluppi. Comprensibili nel complesso, ma dimenticabili. Quello riuscito meglio, forse perché gli si è dedicato più screen time, è Mister Terrific, che da freddo calcolatore inizia ad aprirsi all’intelligenza emotiva di Clark e Lois. Menzione speciale per Krypto, forza della natura che condensa l’amore e il rispetto che Gunn ha per gli animali, mostrato in più film. Un cane che, al di là della premessa fantastica, si comporta come il cane che molti di noi hanno avuto: indisciplinato, tonto, iperattivo, ma leale oltre ogni immaginazione. Il finale del film ci spiega anche il perché della sua disubbidienza, ovvero il fatto che la sua padrona è una Kara Zor-El, AKA Supergirl, che qui appare ribelle e scombinata, tratti che ha evidentemente trasmesso a Krypto.
L’approfondimento politico del film, apparentemente di lana grossa nella sua critica frontale al bellicismo e alla xenofobia, si rivela invece più sottile e coraggioso di quanto possa sembrare a prima vista.
Il conflitto tra Boravia e Jarhanapur, con l’invasione brutale da parte della prima, richiama esplicitamente scenari reali come l’aggressione russa in Ucraina o la devastazione in corso a Gaza. Eppure il racconto evita di scadere nella semplificazione ideologica: il dittatore boraviano è dipinto come un criminale psicopatico, certo, ma il suo rapporto ambiguo con gli Stati Uniti insinua dubbi inquietanti sull’equilibrio globale delle alleanze, sulla spregiudicatezza delle superpotenze, sulla effettiva nettezza della linea di demarcazione tra Paesi Buoni e Paesi Cattivi. Una cosa, però, resta chiara: il popolo del Jarhanapur, mai davvero difeso o rappresentato dai suoi invisibili governanti, è povero, affamato, isolato. Ma anche fiero. E quando arriva il momento, è pronto a difendersi con ciò che ha: mattoni, mazze, tubi, ma soprattutto con la voce e con un urlo o un sussurro di speranza.
Il film si interroga spesso anche sulle definizioni di umano e di alieno e il tutto viene sempre ricondotto non alla biologia, alla natura, alla progettazione o all’appartenenza, ma alle scelte, alle azioni, alla consapevolezza. Una riflessione, questa, che si insinua anche nei dettagli più piccoli: come i robo-inservienti di Superman, macchine dichiarate sin da subito come senz’anima, che invece si rivelano capaci di gratitudine, fedeltà, persino rimpianto nel non essere riusciti a proteggere un amico. E allora la domanda si fa più radicale: essere umani è davvero l’unico metro valido per misurare ciò che è giusto, ciò che ha valore? E, soprattutto, chi ha il diritto di stabilirlo?

Tutto ciò viene espresso con sorprendente linearità e coerenza, attraverso scelte registiche, di fotografia e di ritmo sempre pertinenti, sempre funzionali al nucleo drammatico di ciascuna scena, anche negli eccessi e nelle ingenuità. James Gunn si conferma un maestro nel come raccontare una storia, qualunque storia, per farla arrivare nel modo più diretto e potente possibile. Il risultato è un cinecomic anti-epico che prende posizioni con intelligenza, ma prima ancora un film di genere, un blockbuster d’azione che riesce a parlare di guerra, di potere, di identità e di umanità senza però dimenticarsi della meraviglia, della luminosità, del divertimento.
E forse è proprio qui, nell’equilibrio della leggerezza descritta a suo tempo da Italo Calvino, quel planare dall’alto senza macigni sul cuore, che Superman ritrova la sua forza e alcuni di noi ritrovano la volontà di identificarsi in ciò che lui rappresenta: un ideale alto, limpido, potente e, sopra ogni altra cosa, alla portata di tutte e tutti.
About the author
Classe ‘92. Laureato in/appassionato di: lingue, letterature e culture straniere. Giornalista pubblicista, divoratore di storie, scribacchino di pensieri propri e traduttore di idee altrui.